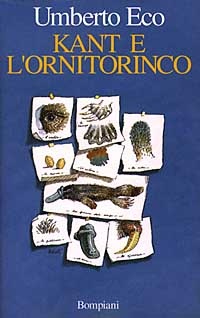 Spesso, di fronte a un fenomeno sconosciuto, si reagisce per approssimazione: si cerca quel ritaglio di contenuto, già presente nella nostra enciclopedia, che bene o male sembra rendere ragione del fatto nuovo. Un esempio lo troviamo in Marco Polo, che a Giava vede dei rinoceronti. Ma si tratta di animali che lui non ha mai visto. Siccome la sua cultura gli metteva a disposizione la nozione di unicorno, come appunto di quadrupede con un corno sul muso, egli designa quegli animali come unicorni.
Spesso, di fronte a un fenomeno sconosciuto, si reagisce per approssimazione: si cerca quel ritaglio di contenuto, già presente nella nostra enciclopedia, che bene o male sembra rendere ragione del fatto nuovo. Un esempio lo troviamo in Marco Polo, che a Giava vede dei rinoceronti. Ma si tratta di animali che lui non ha mai visto. Siccome la sua cultura gli metteva a disposizione la nozione di unicorno, come appunto di quadrupede con un corno sul muso, egli designa quegli animali come unicorni.
L’ornitorinco viene scoperto in Australia a fine Settecento. Nel 1798 un naturalista invia al British Museum la pelle impagliata di un animaletto che i coloni australiani usavano chiamare watermole, duck-mole, o duckbilled platypus. L’animale fa pensare subito al becco di un’anatra innestato sulla testa di un quadrupede e ritenuto opera dei diabolici tassidermisti cinesi, abilissimi nell’innestare, per esempio, una coda di pesce in corpi di scimmia per creare dei mostri sirenoidi. Nel 1800 viene descritto come un animale con triplice natura di pesce, di uccello e di quadrupede e nominato paradoxus perché incategorizzabile. Nel 1802 si vede che l’animale viene a galla per respirare e si pensa a un mammifero, ma non ha ghiandole mammarie con capezzoli ed è oviparo come uccelli e rettili. Nel 1803 si crea la categoria dei monotremi: non sono mammiferi perché non hanno ghiandole mammarie (in realtà vengono scoperte nel 1824, ma sono senza capezzoli, hanno dei pori che secernono latte), non sono uccelli perché non hanno ali, non sono rettili perché sono a sangue caldo e non possono essere neppure pesci. Il dibattito continua e solo nel 1884 si stabilisce che i monotremi sono mammiferi e ovipari.
Il primo tentativo di capire quello che si vede è inquadrare l’esperienza in un sistema categoriale precedente. Ma allo stesso tempo le osservazioni mettono in crisi il quadro categoriale, e allora si cerca di riadattare il quadro. Kant dice che i concetti empirici non possono venire definiti una volta per tutte come i concetti matematici, ma ammettono un primo nucleo intorno al quale poi si raggrumeranno (o si ordineranno armoniosamente) le successive definizioni.
Se lo schema dei concetti empirici è un costrutto che cerca di rendere pensabili gli oggetti e se dei concetti empirici non si può dare sintesi mai compiuta, perché nell’esperienza si possono scoprire sempre nuove note del concetto, allora gli schemi stessi non potranno che essere revisibili, fallibili, destinati a evolversi nel tempo. Se i concetti puri dell’intelletto potevano costituire una sorta di repertorio intemporale, i concetti empirici non possono che diventare storici, o culturali.
Kant non ha detto questo, ma pare difficile non dirlo se si porta alle sue ultime conseguenze la dottrina dello schematismo. Naturalmente a questo punto anche il trascendentalismo subirà la sua rivoluzione copernicana. La garanzia che le nostre ipotesi siano giuste non sarà più cercata nell’a priori dell’intelletto puro bensì nel consenso, storico, progressivo, temporale, della Comunità. Il trascendentale si storicizza, diventa un accumulo di interpretazioni accettate dopo un processo di discussione, selezione, ripudio.
Oppure si può dare il caso che, come ho visto su un'immagine postata da un mio ormai ex-studente su facebook, questa paradossale creatura che è l'ornitorinco derivi da una fusione à la Dragonball tra un'anatra e un castoro. O l'esito di un matrimonio inter-specie.





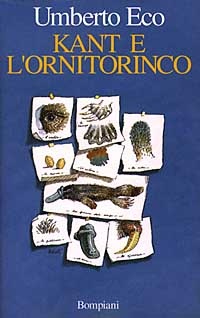 Spesso, di fronte a un fenomeno sconosciuto, si reagisce per approssimazione: si cerca quel ritaglio di contenuto, già presente nella nostra enciclopedia, che bene o male sembra rendere ragione del fatto nuovo. Un esempio lo troviamo in Marco Polo, che a Giava vede dei rinoceronti. Ma si tratta di animali che lui non ha mai visto. Siccome la sua cultura gli metteva a disposizione la nozione di unicorno, come appunto di quadrupede con un corno sul muso, egli designa quegli animali come unicorni.
Spesso, di fronte a un fenomeno sconosciuto, si reagisce per approssimazione: si cerca quel ritaglio di contenuto, già presente nella nostra enciclopedia, che bene o male sembra rendere ragione del fatto nuovo. Un esempio lo troviamo in Marco Polo, che a Giava vede dei rinoceronti. Ma si tratta di animali che lui non ha mai visto. Siccome la sua cultura gli metteva a disposizione la nozione di unicorno, come appunto di quadrupede con un corno sul muso, egli designa quegli animali come unicorni. Con Actarus Claudio Morici ci racconta la vera storia di un pilota di robot, tra problemi di alcolismo, incomprensioni sul lavoro, costruzione mediatica del personaggio, voglia di prendersi una vacanza perché non si può costantemente pensare a salvare il mondo, è logorante. Qualche momento ironico e divertente il libro ce l'ha, è vero, ma le sue qualità non vanno molto oltre a questo.
Con Actarus Claudio Morici ci racconta la vera storia di un pilota di robot, tra problemi di alcolismo, incomprensioni sul lavoro, costruzione mediatica del personaggio, voglia di prendersi una vacanza perché non si può costantemente pensare a salvare il mondo, è logorante. Qualche momento ironico e divertente il libro ce l'ha, è vero, ma le sue qualità non vanno molto oltre a questo.