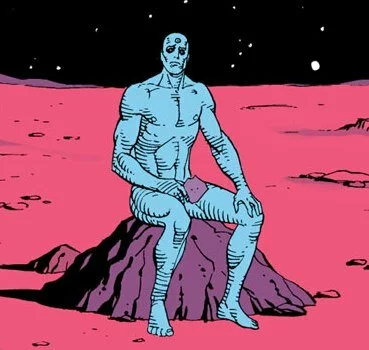È merito di Norbert Elias aver mostrato nel suo Saggio sul tempo (1984) come e in che modo la moderna «società disciplinare» abbia costretto l’uomo a interiorizzare e ad accettare come «naturali» le strutture del nuovo tempo della storia, come il tempo dell’esistenza sia una variabile dipendente dai ritmi della società e dei suoi processi di trasformazione. Non vi è ambito dell’esistenza umana che non sia stato travolto dal processo di accelerazione che ha elettrizzato la modernità in ogni sua determinazione («mobilitazione totale» è l’espressione di Ernst Jünger) e la differenza tra «tempo della vita» e «tempo del mondo» si è gradualmente trasformata in un abisso (Hans Blumenberg, Tempo della vita e tempo del mondo, 1986): il primo, con i suoi ritmi biologici, naturali, ciclici, è stato costretto ad adeguarsi ai tempi linearizzati e sempre più rapidi della storia, sia sul lato socio-politico, sia su quello tecnico-scientifico ed economico, le attività umane sono state chiamate a fare propri i tempi incalzanti della storia uniformandosi al loro andamento accelerato e, di conseguenza, mettendosi esse stesse al galoppo, nella costante sensazione che fosse sempre troppo scarso il tempo a disposizione per agire in un mondo in cui tutto procede così concitatamente.
È merito di Norbert Elias aver mostrato nel suo Saggio sul tempo (1984) come e in che modo la moderna «società disciplinare» abbia costretto l’uomo a interiorizzare e ad accettare come «naturali» le strutture del nuovo tempo della storia, come il tempo dell’esistenza sia una variabile dipendente dai ritmi della società e dei suoi processi di trasformazione. Non vi è ambito dell’esistenza umana che non sia stato travolto dal processo di accelerazione che ha elettrizzato la modernità in ogni sua determinazione («mobilitazione totale» è l’espressione di Ernst Jünger) e la differenza tra «tempo della vita» e «tempo del mondo» si è gradualmente trasformata in un abisso (Hans Blumenberg, Tempo della vita e tempo del mondo, 1986): il primo, con i suoi ritmi biologici, naturali, ciclici, è stato costretto ad adeguarsi ai tempi linearizzati e sempre più rapidi della storia, sia sul lato socio-politico, sia su quello tecnico-scientifico ed economico, le attività umane sono state chiamate a fare propri i tempi incalzanti della storia uniformandosi al loro andamento accelerato e, di conseguenza, mettendosi esse stesse al galoppo, nella costante sensazione che fosse sempre troppo scarso il tempo a disposizione per agire in un mondo in cui tutto procede così concitatamente.Ma c’è una differenza capitale tra la tradizione del tema della brevità dell’esistenza umana e del tempo scarso (Seneca, Orazio) e la concezione moderna: per la prima il tempo è comunque inteso come un possesso pienamente umano, di cui noi stessi siamo amministratori e possiamo saggiamente ottimizzarlo; con la modernità il tempo si autonomizza e diventa padrone della nostra esistenza.
Il caffè è trasformato ben presto in metafora della sobrietà e dunque della razionalità illuministica, oltre che della produttività in grado di accelerare se stessa convertendo in ore lavorative quelle tradizionalmente consacrate al riposo (il sonno dell’organismo è accusato di frenare la produzione e l’incremento dei suoi ritmi). La rivista fondata da Pietro Verri e dal suo gruppo, nel 1764, venne intitolata «Il Caffè» anche perché voleva essere un tributo a quella bevanda miracolosa, emblema della lucidità della ragione. Nell’Histoire de France, Michelet si spinge a salutare il caffè come la bevanda che aveva riportato alla sobrietà un’intera epoca, svegliando l’umanità dal suo torpore millenario. Trovava un suo alleato nel caffè non soltanto la ragione, che grazie ad esso poteva essere ancora più vigile e desta, ma anche la produzione industriale, a cui la «bevanda nera» garantiva corpi scattanti, veloci e iperattivi, nemici dell’ozio e della lentezza. È come se il caffè avesse contribuito a plasmare un nuovo «corpo razionalistico e borghesemente progressista» (Schivelbusch, Il paradiso, il gusto e il buonsenso), sempre sveglio, agile, perfettamente funzionale allo «spirito borghese» e alla sua tensione alla valorizzazione del profitto: il caffè rivestì la funzione di sincronizzare la vita umana con i ritmi accelerati della modernità, favorendo l’accelerazione della storia.
Particolarmente significativo è il fatto che l’aristocrazia, per tutto il secolo XVIII, volle mantenersi con sospetto a debita distanza dal caffè, preferendo un’altra bevanda, la cioccolata, che sembra sortire esiti opposti, favorendo «quello stadio intermedio fra il giacere e lo stare seduti» (ibid.), diventando così una rivendicazione dei ritmi «molli» e pacati del mondo premoderno.
Non va del resto trascurata la diffusione dell’acquavite: anch’essa frutto dell’accelerazione avviata dalla Rivoluzione industriale e da quella francese, intercetta il favore soprattutto della classe operaia. Il caffè fu borghese, la cioccolata fu aristocratica e l’acquavite fu per sua vocazione proletaria: essa permetteva ai lavoratori salariati di ubriacarsi in tempi rapidissimi, trovando nell’alcol – come ricorda Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 – la sola fuga momentanea dalla propria condizione alienata. Di fronte alla velocità vertiginosa della vita in fabbrica, l’operaio reagisce a casa velocizzando il tempo di abbandono della propria sobrietà, quasi come se non aspirasse ad altro se non a congedarsi al più presto, almeno temporaneamente, dai ritmi insostenibili del sistema capitalistico e della sua razionalità produttivistica, attraverso una fuga verso l’ubriacatura accelerata.
Nella Certosa di Parma (1838) di Stendhal, nel vortice degli eventi della battaglia di Waterloo, Fabrizio perde l’orientamento, tra palle di cannone fischianti, disertori allo sbaraglio e furti di cavalli e, al culmine dello spaesamento, non vede altra soluzione che trangugiare avidamente l’acquavite per non essere travolto da quei ritmi frenetici: «la massimizzazione dell’effetto, l’accelerazione dei tempi e la riduzione del prezzo fanno dell’acquavite un vero prodotto della rivoluzione industriale» (ibid.) e della sua smania di ottenere risultati massimi nel minor tempo possibile, in una vera e propria «fretta etilistica». Quest’ultima è elogiata, nel 1863, da Baudelaire: «per non essere gli schiavi martirizzati del Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare» (Enivrez-vous).
D’altra parte, il processo di velocizzazione dei tempi della vita affiora in modo lampante non soltanto dalle particolari bevande che vanno diffondendosi, ma anche dal modo specifico in cui cominciano a essere consumate: nei locali vanno sempre più affermandosi i «banconi», che affiancano i tavoli e che rendono possibile una abbreviata permanenza nel locale.
Particolarmente significativo è il fatto che l’aristocrazia, per tutto il secolo XVIII, volle mantenersi con sospetto a debita distanza dal caffè, preferendo un’altra bevanda, la cioccolata, che sembra sortire esiti opposti, favorendo «quello stadio intermedio fra il giacere e lo stare seduti» (ibid.), diventando così una rivendicazione dei ritmi «molli» e pacati del mondo premoderno.
Non va del resto trascurata la diffusione dell’acquavite: anch’essa frutto dell’accelerazione avviata dalla Rivoluzione industriale e da quella francese, intercetta il favore soprattutto della classe operaia. Il caffè fu borghese, la cioccolata fu aristocratica e l’acquavite fu per sua vocazione proletaria: essa permetteva ai lavoratori salariati di ubriacarsi in tempi rapidissimi, trovando nell’alcol – come ricorda Marx nei Manoscritti economico-filosofici del 1844 – la sola fuga momentanea dalla propria condizione alienata. Di fronte alla velocità vertiginosa della vita in fabbrica, l’operaio reagisce a casa velocizzando il tempo di abbandono della propria sobrietà, quasi come se non aspirasse ad altro se non a congedarsi al più presto, almeno temporaneamente, dai ritmi insostenibili del sistema capitalistico e della sua razionalità produttivistica, attraverso una fuga verso l’ubriacatura accelerata.
Nella Certosa di Parma (1838) di Stendhal, nel vortice degli eventi della battaglia di Waterloo, Fabrizio perde l’orientamento, tra palle di cannone fischianti, disertori allo sbaraglio e furti di cavalli e, al culmine dello spaesamento, non vede altra soluzione che trangugiare avidamente l’acquavite per non essere travolto da quei ritmi frenetici: «la massimizzazione dell’effetto, l’accelerazione dei tempi e la riduzione del prezzo fanno dell’acquavite un vero prodotto della rivoluzione industriale» (ibid.) e della sua smania di ottenere risultati massimi nel minor tempo possibile, in una vera e propria «fretta etilistica». Quest’ultima è elogiata, nel 1863, da Baudelaire: «per non essere gli schiavi martirizzati del Tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Di vino, di poesia o di virtù, come vi pare» (Enivrez-vous).
D’altra parte, il processo di velocizzazione dei tempi della vita affiora in modo lampante non soltanto dalle particolari bevande che vanno diffondendosi, ma anche dal modo specifico in cui cominciano a essere consumate: nei locali vanno sempre più affermandosi i «banconi», che affiancano i tavoli e che rendono possibile una abbreviata permanenza nel locale.
Se dall’ambito dei beni liquidi si sposta l’attenzione a quello di un altro genere voluttuario – il fumo –, ci si imbatte in analoghe testimonianze dell’accelerazione dei tempi della vita. Nella misura in cui «il tempo stringe», diventa indispensabile ridurre al minimo gli intervalli di tempo libero, accorciando il più possibile anche le pause dedicate al fumo: in particolare, «nella storia del fumo questa fretta si manifesta nella semplificazione e nell’abbreviazione dei procedimenti usati per fumare» (Schivelbusch, ibid.) e nella sequenza di diversi strumenti porta dalla pipa al sigaro, e da questo alla sigaretta. La sigaretta si trasforma in una nuova e uniforme unità di tempo – il «tempo di una sigaretta».