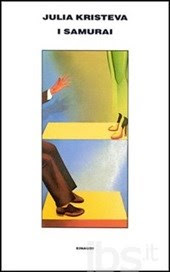Tra gli impegni di fine anno scolastico e gli Esami di Stato - conclusi venerdì scorso -, giugno mi ha visto incapace di pubblicare post, neanche un rapido resoconto finale delle letture del mese. A fine luglio pubblicherò quindi un post con le letture di questi ultimi due mesi. Intanto provo a fare qualche altro post, a partire da questo che è relativo al saggio The Claremont Run. Subverting Gender in the X-Men, scritto da J. Andrew Deman.
Avendo scritto Uncanny X-Men dal 1975 al 1991 (dal numero 97 al numero 278), Chris Claremont vanta una posizione preminente e un'influenza sulla cultura popolare - essendo durante la sua gestione quello degli X-Men il fumetto più venduto - uniche. Uno dei grandi punti di forza della scrittura di Claremont è stata l'ampia cosmologia di personaggi maschili e femminili che è stato capace di presentare, e i vari modi in cui marcatori identitari quali etnia, nazionalità, religione, età, classe e sessualità si sono intrecciati tra di loro e con le prestazioni di genere di ogni personaggio. In questo modo la lunga gestione dell'autore ha saputo rappresentare una forte messa in discussione della fissità di ruoli di genere che il mondo del fumetto ancora rappresentava.
La prima parte del saggio è dedicata all'analisi e all'esplorazione di alcuni dei personaggi femminili principali della gestione di Claremont. Jean Grey/Fenice rappresenta il fondamentale ritratto dell'agency femminile, cioè della capacità femminile di agire, prendere decisioni e avere un impatto sul proprio ambiente e sulla propria vita, della capacità di essere un agente causale, di fare accadere le cose attraverso le proprie azioni. Ororo Munroe/Tempesta è stata la prima leader di un gruppo supereroistico donna e la prima leader di colore, nonché portatrice di comportamenti di genere non normativi, garantendo così una particolare enfasi su un femminismo intersezionale. E, nella seconda generazione di personaggi femminili, abbiamo Betsy Braddock/Psylocke, che dialoga con il concetto lacaniano di mascherata femminile esprimendo la propria in senso ironico, e Alison Blaire/Dazzler, che permette di esplorare le forme tossiche della mascolinità.
La seconda parte, invece, indaga gli altrettanto interessanti personaggi maschili. Scott Summers/Ciclope impersona l'ansia culturale del cambiamento del paradigma patriarcale come risposta diretta alla seconda ondata del femminismo, ma dal sentirsi minacciato riesce poi progressivamente a distanziarsi dall'egemonia maschile di cui era emblema. Logan/Wolverine, da una parte connesso a archetipi maschili della cultura popolare quali il cowboy e il samurai, si dimostra capace di minare quella stessa mascolinità di cui sembra essere fatto. Infine, Kurt Wagner/Nightcrawler e Alex Summer/Havok sono personaggi piuttosto refrattari rispetto alla rappresentazione della mascolinità, minando la connessione tra il ruolo del supereroe e tale ideale.