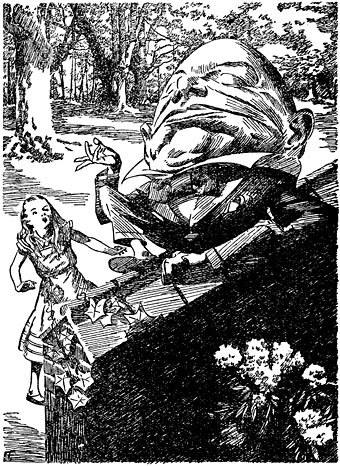Nella
Terza Età, il concilio degli dei decise di inviare dall’Ovest
nella Terra di Mezzo gli Istari, un gruppo di “stregoni”, al fine
di contrastare la crescita dell’ombra di Sauron. Uno, l’ultimo
venuto, all’Ovest si chiamava Olorin, che vuol dire sogno,
immaginazione, memoria, chiara visione di cose non fisicamente
presenti. Tra gli Elfi, nella Terra di Mezzo, fu chiamato Mithrandir,
il Pellegrino Grigio, poiché non dimorava in nessun luogo e non
ambiva a ricchezze né a seguaci, ma andava sempre di qua e di là
per la Terra di Mezzo facendo amicizia con tutte le genti in tempo di
bisogno. L’Elfo Guardiano, Cirdan, indovinò in lui il massimo
spirito e il più realmente sapiente, e gli affidò il Terzo Anello,
Narya il Rosso. Cordiale e sollecito era infatti il suo spirito, egli
era colui che si opponeva al fuoco che distrugge con il fuoco che
illumina e soccorre.
Pur
essendo uno degli Istari Gandalf non si è mai fermato, e si è
mescolato a tutte le razze e a tutte le storie degli abitanti della
Terra di Mezzo. Amico dei signori degli Elfi e dei re degli Uomini,
nemico epocale del maledetto Sauron, godeva molto della compagnia
degli Hobbit; nei loro curati giardinetti, dopo un pasto abbondante,
amava fumare la pipa e chiacchierare su tutto un po’, mentre il
sole dei pomeriggi autunnali sarebbe calato solo – lentamente
aprendo le ombre sull’erba appena innaffiata – per dar spazio
all’allegria della cena con gli ospiti.
Gandalf
sapeva affrontare molte situazioni e trattare con molti caratteri,
perché si coinvolgeva ma non si imponeva, perché era profondamente
democratico, senza ombra di snobismo ed alterigia. Sapeva cavalcare
veloce, maneggiare terribile la spada, amava i boschi verde cupo e i
candidi ghiacciai aperti sul cielo infinito, amava i giochi e le
fantasie, le leggende e i poemi romantici d’amore e morte.

Nella
Contea tutti gli Hobbit sono ignoranti attuali: ma tra di loro alcuni
sono anche ignoranti potenziali – coloro che chiudono occhi e
orecchie ai grandi avvenimenti della Terra di Mezzo, avvenimenti che
però, volenti o nolenti, comunque li coinvolgono – mentre altri
sono potenziali sapienti: sono Frodo, Sam, Merry e Pipino, che
ascoltano Gandalf, consultano gli Elfi, ammirano gli Uomini, imparano
e crescono e saranno gli unici a saper fronteggiare la marea che
arriverà a sommergere la stessa pacifica Contea. D’altra parte, ci
sono i sapienti attuali, per esempio gli Istari (gli “stregoni”),
e tra essi c’è chi è ignorante potenziale, come Saruman Curunir,
che corrompe la sapienza posseduta e diventa progressivamente cieco,
incapace di imparare dall’esperienza, e c’è chi è anche
potenziale sapiente, come Gandalf Mithrandir, che tutti ascolta e da
tutti impara, e nel suo socratico “so di non sapere” vive la sua
vocazione di ricercatore e di testimone della verità.
Il
contrasto tra la suggestione narcisistica e l’esemplarità buona è
quello – nel romanzo di Tolkien – tra Saruman e Gandalf. La voce
idealizzata di Saruman era un’illusione, ma con tutta la potenza
dell’illusione:
«Per
alcuni l’incantesimo durava solo finché la voce si rivolgeva a
loro personalmente, e quando parlava a qualcun altro essi sorridevano
come chi ha indovinato il trucco di un prestigiatore, mentre gli
altri sono ancora sbalorditi. A molti bastava udirne il suono per
esserne avvinti; vi erano infine i succubi, coloro che rimanevano
vittime dell’incantesimo e che ovunque fossero udivano la dolce
voce bisbigliare istigandoli».
Pensa,
invece, a Gandalf, “capo” senza attributi vistosi, senza pompe né
misteri né sceneggiate né minacce né vanità né esibizionismi né
uffici prestabiliti né liturgie sacre.
Il
re Aragorn Elessar lo sa bene e, alla fine della guerra, si fa
incoronare da Gandalf dicendo:
«Lui
è stato il fautore di tutto ciò che è stato compiuto e questa
vittoria è sua».
Il
potere di Gandalf è il dire la verità e – a partire dalle massime
universali fino ad arrivare ai consigli pratici e necessari occasione
per occasione – il permettere che gli altri abbiano intorno a sé
l’ambiente idoneo per pensarla in proprio. Alla fine delle singole
storie dei membri della Compagnia, nessuno dipende da Gandalf o cerca
di imitare Gandalf: gli hobbit rimangono hobbit, ma più felicemente
e pienamente hobbit; gli uomini rimangono uomini ma più pienamente
uomini; chi doveva portare l’Anello riesce a portarlo; chi doveva
diventare re lo diventa; chi voleva sposarsi si sposa; chi voleva
vivere e non morire vive.
E
Gandalf parte dai Rifugi Oscuri senza portare via niente dalla Terra
di Mezzo: il suo “potere”, veramente efficace, non è, alla fine,
nel far dipendere gli altri da sé, ma nel contribuire a farli vivere
non dipendenti da nessuno e sempre più amici tra loro.
(da Franco Manni, Lettera
ad un amico della Terra di Mezzo)













.jpg)