Nuovo set Lego è L'evoluzione delle STEM, cioè delle discipline scientifico-tecnologiche (science, technology, engineering, mathematics).
Il set realizza un libro in mattoncini pieno di scoperte, un’enciclopedia aperta piena di mini costruzioni che simboleggiano alcune delle più famose scoperte scientifiche e tecnologiche e celebrano l’evoluzione della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.
Su una base a forma di libro aperto, appunto, trovano spazio il melo che ha ispirato la teoria della gravità, lo spettro visibile della luce che mostra i colori tra l'infrarosso e l'ultravioletto, il codice di trasmissione fatto di punti e linee inventato da Samuel Morse nel 1836, l'atomo di carbonio sul quale è basata tutta la vita sulla terra, il filamento di DNA, il modello di uno dei primi computer domestici, la sezione aurea derivante dalla serie di Fibonacci e visibile quasi ovunque in natura dalla struttura delle cellule all'orbita dei pianeti, la sonda Voyager 1 ovvero l'oggetto fatto dall'uomo più lontano dalla Terra e il primo veicolo spaziale a raggiungere lo spazio interstellare, il disco d'oro a bordo di tale sonda con i suoi saluti in 55 lingue e la sua selezione di musica e suoni naturali. lo space shuttle che rappresenta lo spirito pionieristico dell'umanità e segna gli incredibili risultati del volo spaziale con equipaggio, il calabrone vitale a mantenere un ecosistema globale sano e la biodiversità.
Inoltre, sono comprese le minifigures di Sir Isaac Newton (1643-1727) - matematico, fisico, astronomo, filosofo naturale inglese, considerato uno dei più grandi scienziati di tutti i tempi e noto soprattutto per la fondazione della meccanica classica, la teoria della gravitazione universale e l'invenzione del calcolo differenziale, contribuì significativamente a più branche del sapere, occupando una posizione di preminente rilievo nella storia della scienza e della cultura -, George Washington Carver (1864-1943) - agronomo statunitense ed educatore nel campo dell'agronomia, insegnò sul campo a ex-schiavi le tecniche di agricoltura per l'autosufficienza -, Marie Curie (1867-1934) - fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese, prima donna insignita del premio Nobel, una dei cinque vincitori del Nobel ad averne ricevuti due e sola a aver vinto il premio in due distinti campi scientifici.
Review: Thaw of Spring
21 ore fa








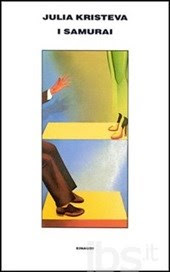




.jpg)












